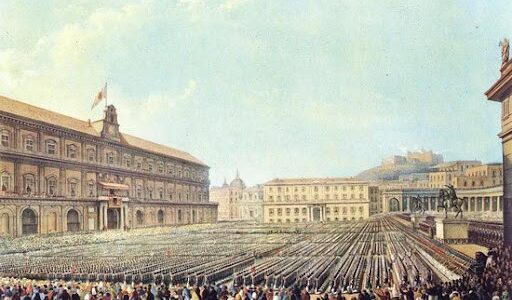La Genovese piatto Napoletano doc: Ma perché si chiama cosi?

La Genovese piatto Napoletano doc che molti inopportunamente associano alla cucina Ligure.
Luciano De Crescenzo spiega come mai a Napoli hanno voluto chiamare “genovese” questa prelibatezza
Da quando vivo a Roma, non sempre ho la possibilità di assaporare piatti della tradizione culinaria napoletana, tranne in occasione di cene in compagnia di amici “emigrati” come me, e che mi deliziano con la loro cucina che farebbe invidia a qualsiasi chef. È inutile dire che la cucina che preferisco è quella della mia amica Marisa Laurito. Ora, se qualcuno mi chiedesse quale piatto tipico napoletano mi piacerebbe mangiare in questo momento, di sicuro non esiterei a rispondere: la genovese. Da non confondere con il pesto alla genovese, che è tutta un’altra cosa.
La Genovese piatto Napoletano
Forse vi starete chiedendo: “Ma com’è possibile, un piatto napoletano che si chiama genovese?”. Ebbene sì, avete capito bene, il ragù alla genovese è una squisitezza della nostra tradizione, anche se sulla sua storia esistono diverse scuole di pensiero.
Secondo alcuni, prende il nome dall’origine geografica dei cuochi che, in epoca aragonese, gestivano le locande che si trovavano nella zona del porto. Questi cuochi, che a quanto pare provenivano da Genova, erano soliti condire la pasta con un sugo a base di cipolle e carne. Per questo motivo il sugo in questione fu denominato genovese.
Secondo altri, invece, il cuoco che inventò questo piatto era un napoletano DOC. A questo punto, però, due sono le versioni di questa storia: secondo la prima, il cuoco in questione era chiamato “’o genovese” e da questo nomignolo venne fuori anche il nome del piatto. Stando alla seconda versione, invece, questo cuoco lavorava nella zona portuale in una taverna che si trovava nel vicolo dei Genovesi.
Io in diverse occasioni ho provato a cercare questo vicolo, ma a quanto pare non esiste più. A parte questo piccolo particolare, la taverna era frequentata perlopiù da marinai di passaggio, che durante le pause sulla terraferma non potevano fare a meno di gustare quel piatto a base di cipolle e avanzi di maiale. In quel periodo, infatti, la carne era un alimento prezioso, e il cuoco, al passaggio del carrettino che la vendeva, era solito comprare gli avanzi che nessuno aveva voluto e che quindi avevano un prezzo più basso. Quindi, il piatto avrebbe preso il nome dalla strada in cui si trovava la taverna.
Mi auguro che i genovesi non si offendano, ma per una motivazione puramente affettiva mi piace pensare che il motivo per il quale la genovese è chiamata così derivi da una di queste due versioni, e che a inventare questo piatto sia stato un napoletano.
Dovete sapere, infatti, che io con la genovese ho un legame particolare, non solo perché è uno dei miei piatti preferiti, ma anche perché quello della sua preparazione era uno dei principali argomenti di discussione tra mio padre e zio Alberto.
Durante la Seconda guerra mondiale, e in particolare nel periodo dei bombardamenti su Napoli, fare la spesa non era un’operazione così semplice, soprattutto se si veniva raggruppati in un campo di concentramento, come accadde alla mia famiglia, che si ritrovò in quello di Cassino. Spesso capitava di andare a dormire senza aver cenato, e non perché si stava seguendo una dieta.
Ecco, probabilmente, e aggiungerei per fortuna, pochi di voi hanno provato realmente cosa significhi “aver fame”. Vi assicuro che tentare di addormentarsi con il brontolio del proprio stomaco vuoto in sottofondo non era poi così piacevole. Per questo, una volta a letto, l’immaginazione divagava alla ricerca del ricordo lontano di un sapore impossibile da gustare. Sembrava che il tempo non passasse mai, e nell’attesa che il sonno avesse la meglio sulla fame c’era sempre qualcuno che dava vita ad articolate disquisizioni sul cibo.
Mio padre era un fervente sostenitore della pasta e fagioli, zio Alberto, invece, non avrebbe mangiato nient’altro se non un bel piatto di fusilli alla genovese. Oltre che sulla scelta del piatto, la polemica era solita proseguire sulla modalità di preparazione.
A dare inizio alla querelle era sempre zio Alberto.
“Voi di Santa Lucia non la sapete fare” esordiva.
A parte gli ingredienti, ciò che rendeva la genovese speciale era il tempo di cottura.
“E a corso Garibaldi quanto la fate cuocere?” chiedeva mio padre.
“Due ore, due ore e mezzo. Cottura rigorosamente a fuoco lento” ribatteva zio Alberto.
“Che schifezza, praticamente la servite cruda!” rispondeva mio padre.
“Ma quale cruda e cruda, non è mica un ragù, che deve pippiare! Il tempo di cottura lo decide la cipolla, a me basta guardarne il colore; non appena si avvicina a quello dell’ambra vuol dire che è cotta.”
A questo punto la polemica diventava sempre più accesa: mio padre sosteneva che la genovese dovesse essere color “manto di monaco”, per zio Alberto il suo colore era l’ambra. Ne era così convinto da aver comprato una giacchetta usata dello stesso colore, che utilizzava come metro cromatico di cottura. Quando la genovese diventava dello stesso colore della giacchetta, a quel punto zio Alberto spegneva i fornelli.